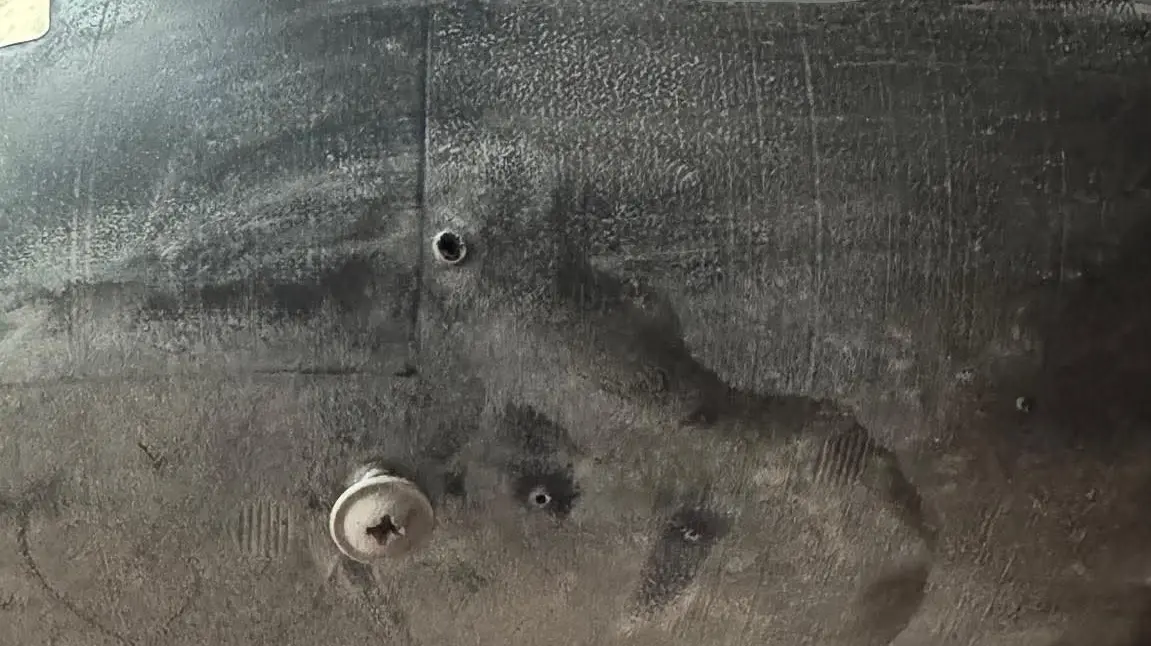Marta dopo il trapianto: scrittrice e fotografa nei paesi devastati

A 29 anni si ammala di leucemia acuta mieloide, poi torna a sperare con un nuovo midollo osseo «Un messaggio agli altri? Ognuno faccia la propria parte, non è facile ma vale la pena»
MARTINSICURO. Il rumore della vita è il click di una macchina fotografica. Anche tra le macerie di un terremoto. Marta Viola ci arriva dieci mesi dopo il trapianto di midollo osseo, 455 giorni dopo che una leucemia acuta mieloide ha stravolto tutte le sue certezze. Quelle di una ragazza di 29 anni laureata in psicologia, con una grande passione per la fotografia, per l’ambiente e per la montagna trasmesse dal padre Mario (nome storico dell’ambientalismo abruzzese), con le giornate frenetiche di chi morde la vita tra progetti, mostre, città e sogni.
In quel luglio del 2016 aveva chiuso la casa di Padova, programmava qualche giorno di vacanza nella sua Martinsicuro e poi di trasferirsi a Milano. «Invece», racconta, «mi sono trasferita in ospedale». Perché in pochi mesi tutto cambia, gli equilibri si perdono e la realtà quotidiana diventa solo quella fatta da ricoveri, chemioterapia, preparazione per il trapianto di midollo osseo. Che arriva il 6 dicembre del 2016 nel centro di eccellenza di Pescara, poi quei 97 giorni di ricovero in una camera sterile, gli alti e bassi di un post trapianto in cui anche fare una doccia diventa un gesto da eroi. A marzo del 2017 il ritorno a casa, la vita che si riaffaccia, la voglia di raccontare e quei 455 giorni che diventano le pagine del suo libro “Sangue bianco”. E poi, ancora, Marta fotografa tra le macerie del terremoto delle Marche e quel suo modo speciale di raccontare che in chi ascolta fa pensare a Italo Calvino quando scrive: «È planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore».
Come ha scoperto la malattia?
«Mi sentivo stanca, ma pensavo a malesseri passeggeri. Pensavo di non essermi riposata abbastanza, di stancarmi muovendomi da un posto all’altro trascinandomi dietro tutte le mie apparecchiature. A Padova sono finita in ospedale perché mi faceva molto male un’anca. Mi hanno detto che poteva essere una infiammazione e mi hanno fatto fare una risonanza magnetica. Nessun emocromo. Qualche settimana dopo mi trovavo a Positano dove stavamo allestendo una mostra con le foto fatte durante il corso a Milano e una mattina mi hanno trovata svenuta nel bagno. Ricordo la corsa in ambulanza all’ospedale Cardarelli di Napoli e poi la diagnosi della leucemia acuta mieloide. Il decorso era stato molto veloce e la situazione non era delle migliori. È subito iniziata la chemioterapia che ha funzionato, ma con quel tipo di malattia il rischio di recidiva è molto alto e per questo la strada del trapianto è diventata una scelta obbligata».
Dopo quando tempo è arrivato il trapianto?
«Nel giro di pochi mesi serviti per trovare un donatore compatibile. Di lui non so niente, solo che ha tre anni meno di me e che è polacco. Poi è arrivato quel fatidico 6 dicembre del 2016 e la firma su quel modulo in cui, nero su bianco, c’erano i numeri del mio futuro con una percentuale di guarigione del 50%, una percentuale di recidiva del 25%, una percentuale di morte del 25%. Perché è giusto che il paziente sappia, che abbia la percezione esatta di quello che accade. Io non ho mai avuto aspettative, ma ho smesso di pensare a tutto il resto. Non ho chiesto, non mi sono illusa né disillusa. Mi sono concentrata su quello che dovevo fare ogni giorno. Ho messo in stand by il mondo di fuori, tutto quello che avrei voluto fare e ho pensato solo al trapianto. Perché ho pensato che lamentarmi, arrabbiarmi, disperarmi non sarebbe servito a niente. Nessuno, se non io stessa, poteva aiutarmi, consolarmi, farmi andare avanti».
Ha mai pensato di non farcela?
«Ci sono stati giorni in cui sentivo il corpo vicino alla morte, in cui anche respirare era faticoso. Ci sono state complicazioni che in un trapianto possono anche essere considerate normali. E, certo, ho anche pensato se valesse la pena sopravvivere per chi e per che cosa. Ma è il pensiero delle persone che ti fa sopravvivere, della mia splendida e forte famiglia, del mio compagno, dei miei tanti amici. Di chi ha saputo sempre come starmi vicino in quelle giornate che hanno segnato il prima e il dopo. E il dopo è quello di un gruppo sanguigno che non è più il tuo, di una vita che ti riprendi giorno dopo giorno con le piccole e le grandi cose. Certo il decorso non è stato facile e posso dire di stare veramente meglio solo da qualche mese. La ripresa è recente».
Il libro che cosa ha significato?
«Dal primo momento che sono entrata in ospedale a Napoli e che ho capito ho pensato di voler fare qualcosa che non doveva servire solo a me. Il libro non è un trattato a posteriori di quello che è successo ma un diario di bordo, un diario quotidiano di quello che è successo. In certi passaggi può essere duro come lo è una malattia, in altri può esserlo meno come il raccontare l’esplosione di gioia che ti arriva per i risultati di un emocromo».
Oggi Marta come pensa al futuro?
«Oggi ho un rapporto più diretto con la vita. Spero, tra qualche mese, di poter riprendere a lavorare. Certo sarà difficile salire su un aereo e partire per l’India come avrei potuto immaginare prima della leucemia, ma riprendermi la mia quotidianità è già una vittoria. Per me che amo la montagna (fa parte del direttivo di Mountain Wilderness ndr) la malattia è stata come fare una scalata senza appigli. Se questa mia esperienza può insegnare qualcosa agli altri allora vorrei che passasse questo messaggio: ognuno deve fare la propria parte. È difficile, lo so. Ma vale la pena».
©RIPRODUZIONE RISERVATA